Facebook e Google non dovrebbero essere i badanti dell’editoria online.
Eppure sembra proprio essere così.
Ogni volta che Google fa una modifica al suo algoritmo di ricerca e dice che punta sulla “qualità”, è pieno di gente che si riempie la bocca della parola “qualità” (e normalmente sono persone che non sono in grado di giudicare, per esempio, la qualità editoriale di un articolo, perché fanno un mestiere diverso da quello giornalistico). Di solito, poi, sono le stesse persone che ti dicono che il SEO è morto. Salvo ricredersi la prima volta che si accorgono quanto sia importante il traffico organico. Ma va be’.
Facebook dice basta al click baiting e ci sono le corse dell’ultim’ora ad adeguarsi (anche se non se ne sono ancora accorti proprio tutti-tutti, ecco).
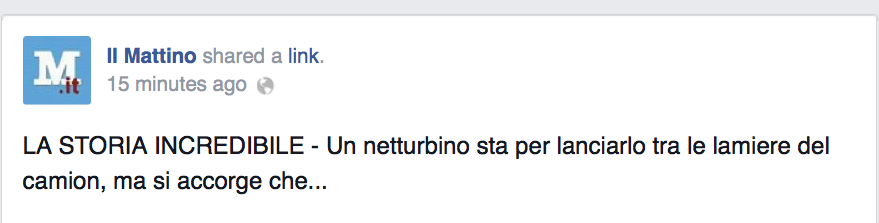
Eppure, basterebbe un piccolo ragionamento per capire che, come dice il saggio, non ha senso chiuder la stalla quando sono scappati i buoi. Cominciamo da una semplice domanda.
Perché Google e Facebook cambiano algoritmo?
Google e Facebook non fanno queste modifiche perché amano particolarmente tutto ciò che è di qualità. Se no, semplicemente, ridurrebbero a zero la visibilità di pezzi con tre righe o di tutto ciò che è “incredibile”, “impossibile”, “pazzesco”.
Non lo fanno, semplicemente perché hanno bisogno che esista tutto questo. E hanno bisogno di fare traffico, e anche di tenerne quanto più possibile al proprio interno, ma allo stesso tempo di offrire un servizio agli utenti. Quale servizio offre Google? La ricerca. Se sono un utente di Google, voglio che i risultati delle ricerche (le SERP) siano quel che cerco. Perché ciò accada, Google deve provare a darmi il risultato migliore sul web. Dico “provare” perché chiunque abbia a che fare quotidianamente con la questione sa benissimo come molti siti siano in cima a Google con contenuti scadenti. Perché il posizionamento dipende da molti fattori. Ma se Google non raffinasse il proprio algoritmo e non tentasse di migliorarsi, gli utenti cercherebbero lentamente altre vie.
Facebook offre il servizio della socializzazione e della condivisione di argomenti di discussione. Se gli utenti cominciano ad assuefarsi e ad annoiarsi e a non essere soddisfatti di quel che viene mostrato loro nel News Feed, cercherebbero altre vie. Non solo: se il mood degli utenti dovesse diventare fortemente negativo (di solito, quando si condivide qualcosa di “incredibile” e l’utente clicca e poi non trova quel che cercava, c’è una percentuale di utenti che torna indietro e ti ricopre di insulti. E sempre di solito, torna indietro molto rapidamente, e riduce così il tempo di permanenza sui tuoi siti), Facebook non ne beneficerebbe affatto, perché ha bisogno che i suoi iscritti siano felici di stare online. Che non insultino troppo i “publisher”. E che i “publisher” continuino a pagare per promuovere i propri contenuti.
In questo senso, anche se su molte keyword Google consente, incoraggia l’acquisto (che pure è ben visibile in SERP) di posizioni su parole chiave, è come se – almeno fino a ieri, dopo l’annuncio di Facebook – il motore di ricerca abbia più “doveri” nei confronti dei propri utenti (ma non dimentichiamoci la Filter Bubble eh).
Insomma, a lungo termine, se a Facebook e Google convenisse, si metterebbero addirittura a fare fact checking. Per poi penalizzare quelli che scrivono o condividono bufale. Non è detto che in futuro non lo facciano (o non annuncino di farlo).
E noi che lavoriamo nell’editoria online non vogliamo, vero, che siano Google e Facebook a fare i fact checkers? Sarebbe uno scenario poco piacevole, giusto? Se siamo d’accordo fin qui, andiamo oltre.
E allora, cosa fare?
La risposta alla domanda, dal mio punto di vista di produttore e coordinatore della produzione di contenuti, è molto semplice: è evidente che Google e Facebook hanno dovuto, devono e dovranno privilegiare un certo tipo di contenuti, per soddisfare le domande degli utenti.
Allora sarà il caso di iniziare a lavorare per tempo su quei contenuti. Di abituare i nostri “follower” e gli algoritmi di Facebook, Google e compagnia bella a trovare contenuti “di qualità”. Cosa vuol dire “di qualità”? In una lezione che ho tenuto per il master WME ho provato a spiegarlo diffusamente e in maniera approfondita. Senza entrare troppo nel dettaglio, per me “di qualità” vuol dire “che risponde perfettamente alla domanda dell’utente” [edit: il senso è da intendersi diversamente dal pericolosissimo “diamo al pubblico ciò che vuole”, troppo simile a bufale, tette e culi, tifo e indignazione da tastiera, che mi fa notare giustamente Carlo Gubitosa. Il senso è: se si vuole “traffico di qualità” e “utenti di qualità” – non litigiosi, che arricchiscono la conversazione, che passano del tempo sui siti e che, magari, sono anche disposti a “spendere” o che comunque possono interessare inserzionisti che hanno una visione un po’ più illuminata della media dell’advertising e del “consumatore” – bisogna rispondere nella maniera più ampia e approfondita possibile alle ricerche su Google e su Facebook degli utenti “di qualità”. Cosa che si può fare sia con l’informazione pesante sia con quella leggera. Facciamo un esempio pratico: se un utente cerca “notizie Gaza” su Google, verosimilmente vorrà essere informato seriamente sul tema. E, per dire, trova in prima pagina su Google Polisblog. Con un pezzo molto lungo, approfondito, diaristico, che infatti ha un altissimo tempo medio di permanenza. Se un utente cerca su Google “Pechino Express“, vorrà sapere tutto sul reality show e troverà l’apposita categoria di TvBlog, contenitore di tutte le notizie sul tema].
Sarà il caso di distinguersi dagli altri per accuratezza e precisione e tempestività. In questo modo, le modifiche agli algoritmi si anticipano, e si può resistere meglio al vento del cambiamento, che a volte può diventar bufera.
Anche perché la reazione classica in questi casi è, generalmente, la risposta immediata ed emergenziale. Che non sempre è la migliore. Insomma, io non ci credo che un editore voglia davvero pubblicare contenuti di scarsa qualità o attrarre con l’inganno utenti che poi non si “convertiranno” mai, né economicamente parlando né parlando in termini di lettori ricorrenti o abituali.
Perché, dunque, aspettare che Facebook e Google diventino le nostre badanti? Non giova a nessuno.
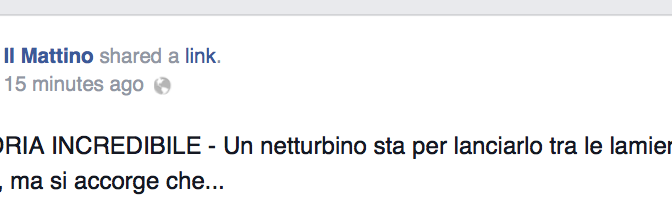
Lascia un commento